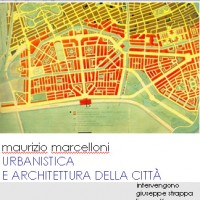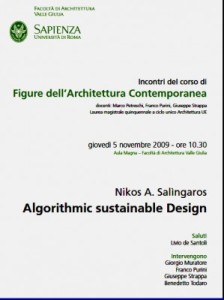L’URBANISTICA E L’ARCHITETTURA DELLA CITTA’
Lezione del prof. Maurizio Marcelloni al corso di Figure dell’Architettura Contemporanea
appunti schematici a cura dell’ arch. Giancarlo Galassi
———————————————–
La lezione inizia richiamandosi al libro di Scipione Guarracino, Le et�
della storia. I concetti di Antico, Medievale, Moderno e Contemporaneo,
(Bruno Mondadori, 2001) nel quale l’autore dimostra che la storia è sempre
finalizzata dagli storici alle proprie dimostrazioni.
Un termine per definire la crisi della città moderna, il passaggio
alla città contemporanea che avviene a partire dalla metà degli anni ’
70 del secolo scorso, può essere quello di “ambiguità”.
Fino agli anni ’50 la città è “compatta” e si sviluppa per addizioni.
L’architetto-urbanista moderno, avendo questo modello di
riferimento, pensa all’ampliamento della città per addizioni in tre
dimensioni.
Al 1942 risale la legge urbanistica n.1150, una legge esemplare che è
stata presa a modello in tutta Europa.
In particolare sanciva che il Piano Regolatore Generale (PRG) è 1) esteso a tutto il territorio comunale 2) valido a tempo indeterminato, aprendo così un campo di lavoro immenso per gli
urbanisti e pianificando una strategia di sviluppo per i successivi 30-
40 anni.
La legge ha cominciato ad essere in realtà applicata, dopo la Ricostruzione,
dalla fine degli anni ’50 e con essa l’urbanistica perde la sua
tridimensionalità.
Numerose figure di urbanisti come Quaroni, Astengo, Samonà, Piccinato,
De Carlo… avevano continuato a impostare il loro lavoro in termini
tridimensionali ma quando l’adozione dei PRG diviene routine
professionale generalizzata, l’urbanistica perde il suo rapporto con la
terza dimensione e a questo si può schematicamente attribuire il rifiuto della pratica
urbanistica da parte di Quaroni mentre Astengo si adegua alle circostanze demandando a
una fase successiva, il Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) il
problema della tridimensionalità.
A partire dalla fine degli anni ’70 si è cominciato a capire che il
PRG non funzionava perchè 1) prevedeva tempi troppo lunghi per il suo
completamento e 2) aveva bisogno di analisi complesse che richiedevano
a loro volta tempi lunghi che andavano ad aggiungersi alle lunghezze
dei tempi tecnici della burocrazia, determinando così, spesso, un
periodo di non meno di 10 anni per l’adozione di un piano.
Quando un PRG diviene legge (ci vogliono in media 10 anni perchè le decisioni prese in fase di progetto divengano norma) la città è già cambiata.
Cosa ha modificato la validità del PRG secondo la legge del ’42? 1)
La crisi economica dovuta al petrolio della metà degli anni ’70 che
mette in diffcioltàla produzione industriale elemento propulsivo della
conurbazione. Una conseguenza di questo fenomeno sono le aree dismesse
all’interno delle città. Utile il merito il testo di Jane Jacobs, Vita
e morte delle grandi città, Einaudi 1961 (rist. 2009).
Altro elemento di modificazione è stato 2) che tra la fine dei ’70 e
l’inizio degli anni ’80 la rivoluzione informatica cambia il modo di
comunicare così come ci ha chiarito nei suoi scritti Manuel Castells.
Ma c’è da dire che, se anche il telelavoro è ancora una prospettiva
importante per migliorare la qualità della vita in città, l’uomo
resterà sempre un’animale sociale e il problema del traffico non può
essere risolto nell’attesa della diffusione del telelavoro.
Ancora 30 anni fa era facile riconoscere un abitante della città da
un residente in un comune del circondario, oggi che la conoscenza, l’
informazione, si è generalizzata, non è possibile più riconoscere un
cittadino da un abitante di un piccolo centro.
Si inizia a pensare di dislocare funzioni urbane importanti nei
comuni circostanti la città, un’operazione che va sotto il nome di
competitività urbana.
Contro la decadenza delle città nascono i cosiddetti Piani
Strategici, ovvero i piani delle 4 / 5 cose che strutturalmente
consentano di far ripartire economicamente una città come accaduto a
Barcellona, a Birmingham e a Bilbao: si tratta di rimettere in modo,
decadute le industrie, il processo economico ricostruendone altrimenti
le basi.
A questo punto il piano del ’42 è in crisi definitiva. Le modalità di
intervento devono essere completamente altre, anche di riavvicinamento
tra architettura e urbanistica.
Ed è il Piano Urbano che fa saltare completamente un PPA e il PRG.
Le novità sono:
1) L’adozione di un Piano Strategico inteso non come piano
urbanistico in senso stretto ma tale da individuare pochi punti di
intervento che abbiano delle ricadute economiche: ad esempio la Nuova
Fiera di Roma vicino all’aereoporto o il nuovo Palazzo dei Cingressi
all’Eur, strutture che dovrebbero far risalire Roma nella classifica
delle città congressuali” (ora è al 75° posto), determinando un
importante indotto così come avvenuto a Barcellona e a Bilbao. Dal
punto di vista gestionale c’è da dire che Roma è molto indietro.
2) mettere in moto, tramite il Piano Strategico, un movimento di
autonomia dei comuni vicini. Cambiando i criteri localizzativi delle
funzioni strategiche si collocano importanti edifici fuori della grande
città secondo un processo di metropolizzazione della periferia.
Le funzioni prima localizzate nel Centro Storico vengono spostate in
piccoli comuni, vedi l’esempio del nuovo centro servizi della Banca d’
Italia a Frascati (4000 addetti).
Si passa così dal concetto di “area metropolitana” a quello di “citt�
metropolitana” proprio per il rapporto dialettico che si stabilisce tra
città e comuni del circondario.
Parigi in proposito si è inventata i grandi progetti di bordo
realizzati al confine tra la città e i comuni vicini.
La città metropolitana è fondata su un policentrismo a geometria
variabile.
3) Cambiare la tradizionale antitesi città-campagna cosicché l’
immagine più vicina alla città contemporanea è quella dell’arcipelago:
Roma come arcipelago metropolitano (Altre definizioni: metapolis, citt�
diffusa) con il vuoto della campagna è all’interno della città di
Roma.
Andrè Corboz in Ordine sparso – Saggi sull’arte, il metodo, la citt�
e il territorio, Angeli 2006, scrive un testo sull’evoluzione dell’
urbanistica (anche su come si fa ricerca) ein particolare definisce il
territorio come palinsesto, il territorio ‘parla’ e definisce la
scomparsa della contrapposizione città-campagna.
Ilya Prigogine (premio Nobel per la chimica) ha sviluppato la Teoria
della Complessità che mette in crisi il positivismo che sosteneva che
la complessità potesse comunque essere disvelata per segmenti.
Prigogine sostiene che la complessità non si disvela, nell’universo
delle possibilità c’è un solo punto fermo: l’incertezza. Occorre
accettare questa incertezza e viverla bene!
L’urbanistica come programmazione non serve più, occorre, piuttosto,
partire dal basso e ogni volta ‘reinventare’. Gli urbanisti che hanno
pianto perché la realtà non andava secondo i loro PRG hanno allora
messo in crisi i loro strumenti (cfr. un articolo di Bernardo Secchi, I
tempi sono cambiati).
I nuovi strumenti che cercano di stare al passo con la complessit�
sono: 1) la Pianificazione Strategica e 2) la Pianificazione
Strutturale. Vengono selezionati solo alcuni elementi che strutturano
il territorio: la viabilità, il sistema ambientale ecc…, tutto il resto
è demandato ad altre figure, a piani locali.
Il vecchio PRG conteneva tutto, oggi invece con una maggiore
flessibilità, si demanda a piani di scala inferiore.
Tra gli strumenti operativi non si parla più di PPA o di
lottizzazione ma di Programmi Integrati (PrIn) che tengono in
considerazione tutti le figure che operano nel territorio.
Il Progetto Urbano diviene uno strumento complesso che interviene su
un pezzo di città trasformandolo fisicamente e funzionalmente. Il
progetto si cala a scala urbana nella realtà esistente contribuendo a
migliorare la qualità della vita delle persone che abitano il
territorio oggetto d’intervento.
I nuovi metodi sono 1) “Pianificar facendo” invertendo il meccanismo
dialettico tra strategie e operazioni concrete di costruttori e
pianificatori. La processualità allora è fondamentale: il piano viene
aggiornato con il contributo di tutti i soggetti coinvolti (le
ferrovie, la regione…).
Il piano di Roma, già attuato in questo senso, ha sconvolto gli
urbanisti.
Insomma: gestione e attuazione camminano insieme.
Altro metodo: 2) Progetto Urbano e Policentrismo: formazione di
grandi magneti di rango urbano che competono con il centro storico e
riqualificano le periferie.
Di fronte alla complessità non ci sono scorciatoie, l’urbanistica
tradizionale ha le armi spuntate.
La sperimentazione ha trovato inoltre, con la recente crisi economica
(una crisi tipica di una società postindustriale) una nuova ragione.
Alla crisi economica si somma poi la crisi ambientale.
In Inghilterra esistono i cosiddetti piani di Transition City che
sperimentano modelli di sviluppo sostenibile prevedendo in 10/15 anni
un cambio di stile di vita.
Per spiegare la complessità proprio Prigogine usa la metafora della
città, esemplare organismo dissipativo cioè in grado di consumare più
di quanto produce.
L’architetto urbanista contemporaneo deve forzare al massimo le
possibilità che gli sono offerte; densificare salvando la
discontinuità, in una condizione di trasformazione continua che
utilizzi la mixité, le funzioni integrate miste.