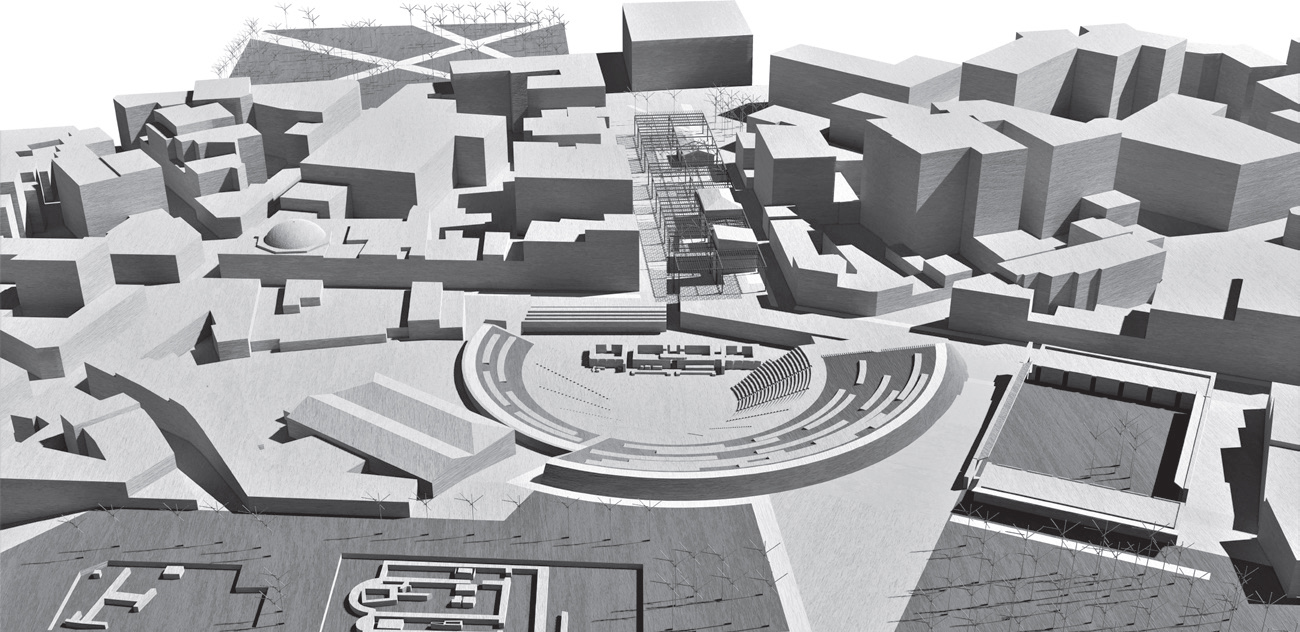LEGGERE LA PERIFERIA CON OCCHI NUOVI
Giuseppe Strappa
Il problema dello studio della nostra periferia, di una città moderna che si è sviluppata in modo contraddittorio nel territorio di confine tra tessuti consolidati e campagna, è quello di leggere un’edilizia nuova sulla quale, al confronto con la bellezza e l’autorità riconosciuta al centro antico, si è consolidato un giudizio sbrigativo di città instabile e vaga, non legittimata dalla storia: senza struttura.
Le tante letture che si sono succedute, dal neorealismo in poi, nella letteratura, nel cinema, nell’architettura, non hanno fatto che rafforzare l’immagine di un indefinito mondo di confine, a volte estremo, trasformando la realtà di quartieri, insediamenti abusivi, intensivi abitativi pubblici o di speculazione, in luoghi della mente tanto verosimili e consolidati da essere accettati come verità: dalla disperazione delle case popolari di Val Melaina in Ladri di biciclette, alla speranza delusa delle abitazioni del Quadraro di Mamma Roma, ai fondali urbani dei drammi di Rossellini, De Sica, Antonioni, Monicelli, Zampa, Pasolini. L’ultimo brandello di ordine cui aggrapparsi prima del naufragio nei casermoni disordinati, sembrava costituito, curiosamente, dalla rigidità del Quartiere Don Bosco, nella versione metafisica che ne ha dato di Fellini o in quella ironica e malinconica di Dino Risi. Oltre questa soglia, astratta e simbolica, si stendeva un territorio di conflitto senza monumenti e senza memoria, che si alimentava di infiniti segni e permetteva infiniti codici.
Una città strabica, peraltro, che ha sperimentato il mito populista della crescita per quartieri indipendenti proprio nel momento di transizione della città da capitale di stampo ancora ottocentesco verso un incerto futuro di metropoli. Che ha continuato a proporre, con i “comparti” del piano del ’62, una crescita per brani isolati in un verde fragile, virtuale, trasformato presto nei prati desolati cui è legata l’immagine letteraria della periferia romana, e saturato poi, a ondate dalle successive, da caotiche espansioni di frettolosa edilizia privata, epilogo inevitabile e provvisorio di un naufragio amministrativo ancora in corso.
Non è stato deliberatamente riconosciuto alla periferia romana quel valore culturale che pure doveva essere evidente, né individuato alcun processo formativo che ne spiegasse ragioni e vocazioni. Eppure la forma del suolo strutturata da lievi crinali già in parte abitati, separati da compluvi dove scorrevano le marrane, ha costituito il riferimento alla struttura di percorsi e perfino alla costruzione dei primi tessuti di speculazione o abusivi degli anni ’50, in un inconscio rispetto di un territorio storico ancora operante. Per questo la sua struttura è stata volutamente ignorata: perché una città senza forma sembrava aprirsi a qualsiasi possibilità e, dunque, a qualsiasi forma, anche alla più apparentemente improvvisata. La colpa è stata attribuita soprattutto alla brutalità degli interventi privati, ai “palazzinari” senza scrupolo. Anche se, credo, qualche responsabilità, seppure marginale, abbiano avuto alcuni interventi “informali” di illustri architetti che, nelle espansioni originate dalla legge 167 del ’62, hanno indicato la strada di un ordine astratto e individualistico di parti isolate di città a fronte di un disordine generale del territorio. Esattamente il contrario di quello che sarebbe servito.
D’altra parte il fallimento del progetto per il Sistema Direzionale Orientale, che avrebbe dovuto organizzare, con i quaranta milioni di metri cubi previsti, l’intera struttura urbana di un’area immensa comprendente Pietralata, il Tiburtino, il Casilino e Centocelle, è stata l’espressione plastica dell’impotenza della politica di fronte ai problemi reali.
La periferia romana sembrava condannata a incarnare l’essenza pittoresca della modernità urbana. Una modernità che ha avuto i suoi cantori, che interpretavano la frammentazione e il disordine urbano come germe di figure in continua rigenerazione. Col risultato concreto di legittimare, in qualche modo, la disinvoltura con la quale ancora oggi si procede per parti o, meglio, per spartizioni, attraverso insediamenti autonomi e tuttavia, non autosufficienti, incapaci di comporsi a formare una vera metropoli. Schegge che si vanno ormai saldando o meglio giustapponendo senza che nessuna struttura razionale, tra polarità immaginarie e centralità rimaste sulla carta, le possa realmente integrare. Le proposte di questi giorni per il nuovo stadio di calcio, contro la stessa cultura contemporanea delle città europee, prevedono strutture autonome d’iniziativa privata: migliaia di metri cubi di nuove abitazioni isolate intorno a un centro vuoto, una struttura separata e monofunzionale. E’ la vittoria del contingente e del casuale, della trattativa tra politica e promoter.
Un dato è evidente dalla constatazione del fallimento del piano del ’90: il “generoso” dimensionamento dell’edilizia privata ha portato a due esiti ugualmente disastrosi.
Da una parte la dilatazione delle quantità realizzabili ha indotto a un notevole abbassamento, oltre che della dotazione di servizi, anche privati, della qualità edilizia dei nuovi quartieri, costruiti con un cinismo sconosciuto perfino agli interventi speculativi dei decenni del dopoguerra; dall’altra il numero elevatissimo delle unità immobiliari immesse sul mercato ha comportato il netto prevalere dell’offerta sulla domanda senza peraltro produrre, com’è avvenuto in altre parti del mondo, una significativa riduzione dei prezzi di vendita. Si ripropone, in altre parole, quel vistoso e devastante fenomeno di rendita di posizione contro cui per decenni si è scagliata la parte più impegnata della cultura architettonica romana ma che ora sembra accettato come inevitabile portato dei tempi. Basta osservare le recenti espansioni di edilizia privata, ormai unica forma di costruzione abitativa, che hanno invaso le aree libere lungo le consolari, per rendersi conto di come i tipi edilizi impiegati siano sostanzialmente gli stessi di quelli degli anni ’80, ma dilatati in altezza e profondità, “gonfiati” dalla labilità delle regole e dalla mancanza di una qualsiasi idea di città. Ritornano perfino gli stessi dettagli, gli stessi balconi, le stesse facciate dove le aperture si affollano banalmente secondo un elenco ignaro di ogni regola, interrotte a volte, senza pudore, da qualche patetico tentativo di “ravvivare” la composizione con improbabili partiti diagonali.
Questo quadro desolante dà conto di una condizione, ma esprime anche, credo, l’urgenza del cambiamento. Istanza particolarmente avvertita da un gruppo di docenti e dottorandi del nostro dottorato Draco in Architettura e Costruzione i quali hanno studiato la possibilità di riconoscere aspetti progressivi in alcuni quartieri della periferia romana costruiti con finanziamenti privati. Quartieri, cioè, realizzati da una categoria imprenditoriale storicamente considerata tra le più arretrate e voraci della Capitale, che ha invece messo in campo, nei casi di studio esaminati, insospettate capacità di scelta e anche, in alcuni casi, di vera ricerca. E’ un dato tanto più rilevante perché riconosciuto in un momento della crescita urbana nel quale la mano pubblica sembra del tutto latitante, avendo da tempo rinunciato a fornire qualsiasi contributo alla qualità della produzione edilizia. E, d’altra parte, assegnando un compito di mediazione alle procedure di progettazione, la politica non ha mai dato troppo peso al ruolo propositivo e innovatore che l’architettura potrebbe svolgere nel ricomporre i pezzi dispersi delle periferie.
I testi che seguono spiegano ampiamente le ragioni scientifiche di questa nuova attenzione per la “città privata” che ha coinvolto criticamente anche la disciplina dell’estimo, spesso confinata, in ricerche come questa, in un ambito di competenze isolato dai problemi dell’architettura della città.
Vorrei però rilevare l’ottimismo con il quale questi docenti e giovani ricercatori hanno guardato a un passato recente nel quale sembrava difficile leggere segnali positivi. Leggendo da progettisti e oltre i luoghi comuni, com’è giusto che sia, anche nel desolato banale quotidiano i segni di un possibile cambiamento.