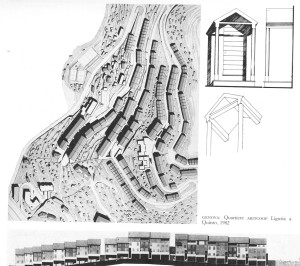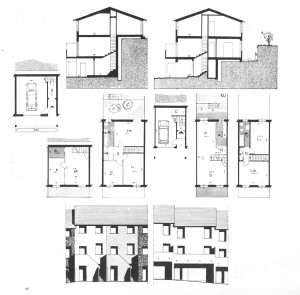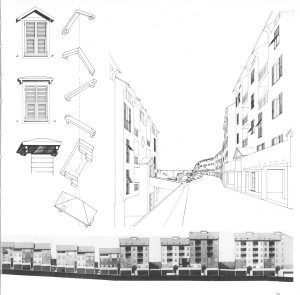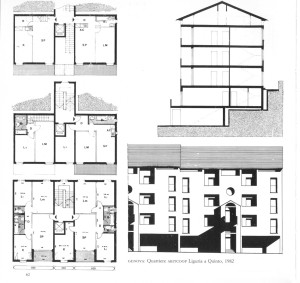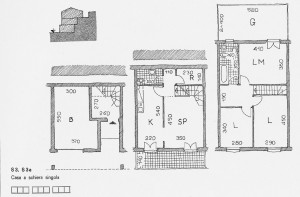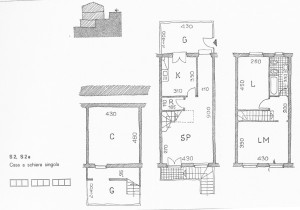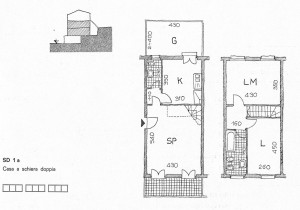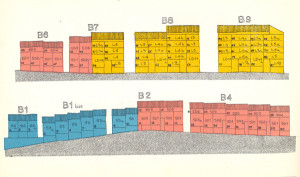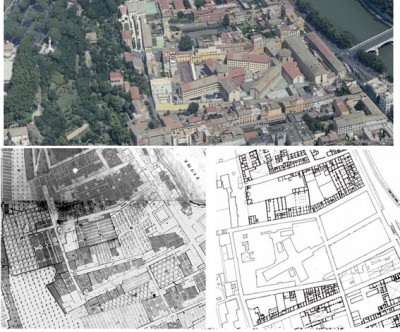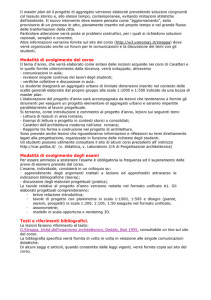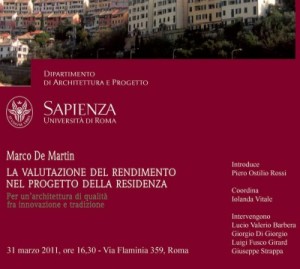di Giuseppe Strappa
in “E42 EUR. Segno e sogno del Novecento”, Roma 2005
DUE TESTI
Collocate sui poli opposti di uno stesso asse viario, due esemplari architetture riassumono, con la perentoria immediatezza delle loro forme, la complessità dei significati racchiusi nell’E.42, quartiere disegnato con i criteri di un organismo unitario in un’epoca in cui le città si andavano dividendo, specializzando, frammentando.
Da una parte il Palazzo della civiltà italiana, il cui asse nodale indica non solo la percorrenza principale dell’organismo architettonico, ma dell’intero tessuto cui appartiene. Qui coesistono, per intero e in modo retoricamente leggibile, tutti i portati dell’ideologia del moderno: la mancanza assoluta di qualsiasi indicazione nella stratificazione organica dell’edificio, di un pur labile accenno alla specializzaizione della parte basamentale, dell’elevazione, dell’unificazione, della conclusione. Con l’estremizzazione, poi, della funzione d’involucro delle facciate, rigiranti in modo meccanico, senza che una qualsiasi nodalità angolare denunci il diverso ruolo dell’ordine delle parti.
Nessuna opera moderna, forse nemmeno quelle dell’avanguardia estrema, contraddice in modo tanto evidente le necessità organico-costruttive dell’edificio espresse dal rapporto leggibile tra le parti: la serie elencata senza alcuna gerarchizzazione, con le arcate ripetute in modo ossessivamente identico, senza che alcuna connotazione stabilisca il ruolo che il singolo elemento svolge rispetto all’intera struttura. E poi l’evidente contraddizione tra il carattere del sistema statico costruttivo a telaio, di matrice elastica, e leggibilità esterna, di derivazione plastico muraria. Contraddizione comune a molte architetture moderne, ma mai esibita in modo tanto perentorio.
L’ astratta assolutezza di questa costruzione è stata inseguita, senza raggiungere un esito tanto estremo, da molte delle architetture dell’epoca, prima tra tutte la proposta di Libera per il municipio di Aprilia, dove l’iterazione dell’arco possedeva, comunque, un’ancora organica gerarchizzazione.
Considerato dalla critica italiana del dopoguerra il simbolo stesso del più veto conservatorismo architettonico, espressione banale di un mondo pacificato dalla semplificazione, il Palazzo della civiltà italiana in realtà, se riguardato nei suoi caratteri costitutivi, si pone all’estremo della modernità intesa come rottura con le nozioni ereditate: una logica seriale tanto assoluta ed estrema da essere comparabile alla serie astratta ed ossessiva impiegata da molta arte figurativa moderna. Così, paradossalmente, un edificio che sembra porsi, se considerato con altri parametri, all’estremo della conservazione più tradizionalista, se letto nella propria lingua, si offre come innovazione tra le più radicali e drammatiche.
Sul polo opposto dell’asse, il Palazzo dei ricevimenti e congressi, nonostante l’apparente, maggiore aggiornamento, testimonia appieno persistenza e vitalità della nozione ereditata di organismo (lo stesso Libera aveva, peraltro, assimilato la sala dei ricevimenti all’impianto di un tempio). Il carattere dell’edificio, massivo, murario, plastico, è il risultato dell’unione di un impianto di derivazione basilicale, con vano centrale nodale e vani seriali collaboranti, e da un secondo impianto nodale costituito dalla sala per i congressi. La vasta, solenne sala riservata ai ricevimenti, è delimitata da un doppio coronamento di pareti che contengono i percorsi verticali. L’intervallo tra le due pareti è necessario tanto a garantire la stabilità verticale attraverso la loro collaborazione reciproca, quanto ad ospitare percorsi verticali: compito assimilabile, per certi versi, alla gerarchizzazione delle navate laterali negli impianti basilicali, che svolgono contemporaneamente un ruolo statico e distributivo. Risolvendo anche qui, con un unico gesto costruttivo, in modo leggibile, il problema statico, distributivo, spaziale, l’architetto coglie pienamente l’aspetto fondamentale dell’organismo architettonico di tradizione romana: quello dell’unità indissolubile nelle componenti che costituiscono l’edificio. Lo stesso spirito sintetico s’individua nella collaborazione tra i vani, indicando come Libera abbia pienamente colto lo spirito unitario della nozione d’organismo. Una nozione aggiornata, certamente, da innovazioni anche radicali, come lo spazio dedicato ai congressi, coperto da un lecorbusieriano “suolo artificiale” e, soprattutto, l’asse centrale passante tra gli interassi dispari del porticato, contraddetto dall’interasse pari dei setti portanti degli ascensori: un pieno incontrato sull’asse nodale che contraddice la nozione stessa di asse inteso come geometrizzazione di un percorso.
Anche l’involucro esterno, quasi in polemica col Palazzo della civiltà, risulta chiaramente gerarchizzato attraverso la distinzione dei ruoli delle parti: portanti e portate, serventi e servite, nodali e seriali. La sequenza della stratificazione architettonica si svolge limpidissima: il crepidoma, che raccorda la scalinata; l’elevazione denunciata all’esterno dalla perimetrazione dei vani seriali sui quali si eleva il volume puro del grande vano per i ricevimenti, l’unificazione appena accennata dalla sottile fascia della cornice, la conclusione della grande copertura metallica che indica, con la sua struttura biassiale, la nodalità del vano sotteso.
UNA LINGUA CONDIVISA
Due testi dunque, quelli cui si è fatto cenno, i cui opposti contenuti sono riconoscibili solo se letti attraverso la stessa lingua. Emerge una considerazione, ovvia eppure inspiegabilmente dimenticata dall’architettura contemporanea, concentrata in larga parte sulla spettacolarità di linguaggi instabili, rapidamente mutevoli: il ruolo fondante di un codice condiviso. Conosciuto, impiegato, trasmesso: al di là delle condanne dei molti critici che hanno interpretato la produzione romana tra le due guerre come naufragio degli ideali moderni (ma anche dalle recenti agiografie che hanno contribuito ad immettere questa complessa vicenda nel circuito di un disinvolto consumo) le architetture dell’E.42 sembrano indicare l’attualità delle matrici formative degli organismi architettonici, il loro possibile aggiornamento, il valore ancora operante, soprattutto, di una lingua comune talmente moderna da essere capace di trasmettere significati opposti e contraddittori.
Le due opere costituiscono i poli di una dialettica che non trova, in realtà, alcuna sintesi. Il Palazzo della civiltà costituisce, più che un’antitesi, la critica necessaria alla presa di coscienza dei caratteri fondamentali dell’E.42 attraverso i quali viene testimoniato, pur tra contraddizioni e fallimenti, il compito di esprimere con evidenza didascalica una diversa idea di modernità come rinnovamento ciclico contro la modernità intesa come progresso continuo: contro la rivoluzione intesa come freccia della storia che indica una sola direzione, la rivoluzione compresa come moto rotatorio che ritorna a ripercorrere (nel suo senso etimologico, conservato in astronomia) gli stessi luoghi in tempi sempre nuovi. Ritorno possibile solo a patto di apprendere la propria posizione e condizione nella sequenza di eventi che hanno concorso a formare la realtà costruita, di riconoscerne forme, etimi, tracce e luoghi attraverso codici ancora operanti.
In questa logica di continuità con i processi riconosciuti nella storia, l’E.42 riassume il rifiuto cosciente della cultura romana di alcune delle più divulgate istanze del movimento moderno perché altre possano emergere con indiscutibile evidenza, cominciando col rifiutare, il ruolo dell’architetto, in fondo ancora tardoromantico, di artista condannato all’innovazione individuale, all’invenzione soggettiva, alla “creatività” comunque riconoscibile: respingendo, in altre parole, quella rottura tra strumenti del progetto e città consolidata che ha contribuito, soprattutto nei primi decenni del secolo scorso, alla progressiva perdita del valore di lingua dell’architettura.
La lingua comune impiegata nel Palazzo dei cogressi (come nel Palazzo degli uffici di Minnucci, nella sede della Mostra della romanità di Aschieri, degli edifici della Piazza imperiale e in tante altre opere dell’E.42), tanto ineludibile da essere compresa e condivisa anche da architetti operanti a Roma ma formatisi in altri ambiti culturali, doveva la sua vitalità e continuità ad una costante pratica di lettura attiva della storia. Dato questo di fondamentale importanza per la comprensione delle opere, eppure del tutto trascurato dagli storiografi del dopoguerra, con alcune rilevanti eccezioni come quella di Nikolaus Pevsner. Decisivo è stato, infatti, l’originale sforzo di sintesi compiuto dagli architetti romani per il rinnovamento degli strumenti del progetto attraverso l’esercizio della “restituzione” come metodo per estrarre dall’insieme dei testi trasmessi dalla storia le regole di una lingua da impiegare nel linguaggio moderno: la ricostruzione dell’ originale organicità dell’opera, condotta attraverso la lettura di trasformazioni tipiche, come comprensione dei processi formativi degli organismi architettonici, allo stesso modo in cui ci si esercita nella traduzione e comprensione dei testi antichi non per imparare una lingua morta, ma per afferrare le radici della lingua moderna.
Le discipline storiche hanno svolto, in questo senso, un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni: se l’insegnamento dell’architettura veniva impartito per mezzo di un vero “organismo didattico” al quale collaboravano, in stretto rapporto di necessità e comunanza di fini, tutte le discipline, lo studio dei monumenti e della loro conservazione forniva il contributo determinante.
A conferma del ruolo progettuale dello studio dei monumenti Gustavo Giovannoni proponeva, di fronte al problema della lettura di un’opera d’architettura, che la restituzione dell’opera cui la lettura del processo formativo conduceva, potesse anche non essere mai realmente esistita.
L’apparente paradosso esprimeva, insieme, la specificità “progettuale” della lettura operante impiegata dall’architetto, ma anche la diffidenza verso metodi mutuati dalle arti visive: quando gli architetti “applicano all’architettura i metodi adatti per le altre arti, in cui la tecnica è semplice ed è subordinata al pensiero artistico – egli diceva – divengono anch’essi dilettanti e spesso anche dilettanti presuntuosi.”. Affermazione che andrebbe attentamente considerata anche nel contesto attuale.
Perché la lingua, forma abbreviata e convenzionale di comunicazione, si apprende, trasmette, impiega (anche in forma poetica) in architettura con metodi specifici e diversi per ogni area culturale. Essa è, insieme, prodotto e origine dell’identità: per questo, anche attraverso le infinite ramificazioni dei linguaggi, la lingua dell’E.42 è immediatamente riconoscibile come specifica di quella cultura architettonica che, consolidatasi negli anni ‘30, continua ad essere compresa almeno fino a tutti gli anni ‘50, prima di divenire lingua morta nell’accelerata Babele dei personalismi che hanno condotto alla crisi contemporanea ed all’afasia.