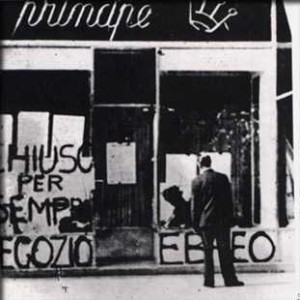di Giuseppe Strappa
in «Corriere della Sera» del 19.01.2005
Il “Serpentone” di Corviale sembra dare ragione a quanti sostengono che l’architettura non risolve i problemi ma li crea. Proprio il suo carattere di utopia costruita che fa tabula rasa della nozione di tessuto, e l’astrattezza del suo generoso, visionario rigore hanno originato, qui, insolubili nodi e conflitti.
Certo, Corviale costituisce il portato estremo e ritardatario di un impossibile modello di periferia urbana che prevedeva smisurate macchine per abitare sparse, come transatlantici, nel mare verde della campagna incontaminata. E tuttavia il significato etico e civile di quest’esperimento può essere compreso nel confronto con la superficialità di tanta architettura contemporanea, con i grattacieli ritorti, piegati, avvitati senza porre altro problema che quello di un sensazionalismo estetizzante, promosso da quegli stessi cultori della deregulation architettonica che attribuiscono il fallimento di Corviale al desiderio di un nuovo ordine delle cose.
Forse per l’attualità del suo contraddittorio messaggio, le università La Sapienza di Roma e Columbia di New York hanno cominciato a riconsiderare, in questi giorni, dopo tante banalizzazioni, questo straordinario “caso di studio”.
Corviale costituisce oggi l’enigmatica rovina del paquebot lecorbusieriano e della sua ideologia. Come in un medioevo selvaggio, si disgrega e ricompone in cerca d’identità: la grande madre di spazi atomizzati, di meandri ingovernabili, ma anche di forme di rinascita civile con spazi per la musica, il ballo, la lettura.
Blade Runner romano e multietnico, il Serpentone è oggi un laboratorio che offre l’immagine concreta e dolorosa della condizione contemporanea, della frantumazione delle forme e delle coscienze. Anche se fossero stati realizzati i servizi previsti non sarebbe mai stato un luogo sereno. Forse lo smarrimento che ne deriva ha indotto molti abitanti a sviluppare una forma di orgoglio dell’appartenenza, dell’abitare un luogo estremo, duro, sperimentale: un sogno fallito e, insieme, un territorio di frontiera da rifondare. Qualcosa di diverso, in ogni modo, dall’avvilimento rassegnato di tante periferie metropolitane.
Per questo occorre resistere alla tentazione di demolire Corviale. E’ necessario, invece, un grande, fiducioso sforzo collettivo per ripensarlo con nuove densità e funzioni: una gigantesca, didattica rovina che disgregandosi, come i grandi organismi antichi, mostra la possibilità di rigenerarsi, di costituire il problematico sostrato di una nuova vita.